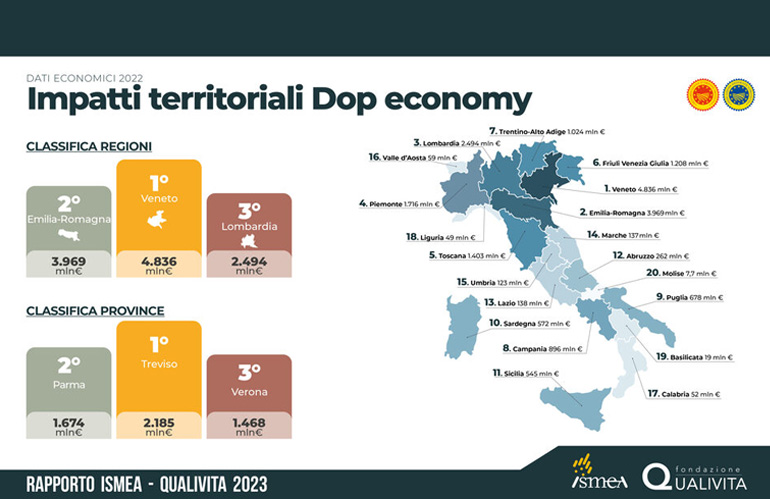Servizi
- Dettagli
- Scritto da Andrea Vitali
A Firenze presentati i dati 2025 di Fondazione Destination Florence e Centro Studi Turistici: 213,7 milioni di euro e oltre 2.860 matrimoni stranieri. Per il 2026 stimata una crescita del +5,3%, con mercato sempre più professionalizzato e orientato alla qualità.
- Dettagli
- Scritto da Redazione Floraviva
La Confederazione Italiana degli Agricoltori Toscana lancia un allarme: in 10 anni persi 20.000 aziende agricole, un segnale inequivocabile, secondo CIA, della crisi che attanaglia il settore. Il presidente di CIA Toscana, Valentino Berni,
- Dettagli
- Scritto da Andrea Vitali
Il 2 dicembre a Pistoia il presidente del Distretto vivaistico ornamentale Ferrini ha aggiornato il ministro dell’agricoltura sullo stato del Distretto (5 mila ettari per 900 mln di fatturato e 6 mila addetti; vari progetti avviati per la sostenibilità) ed evidenziato che i vivai colpiti dall’alluvione «hanno fatto da cassa di espansione subendo danni per milioni di euro» ma mitigando l’impatto sul territorio. Le istanze dei vertici delle associazioni agricole pistoiesi: Magazzini (Confagricoltura),
- Dettagli
- Scritto da Andrea Vitali