Il vivaista
- Dettagli
- Scritto da Andrea Vitali
Il 27 ottobre al Palazzo Comunale di Pistoia la “Serata del vivaismo 2023” organizzata dall’Associazione Vivaisti Italiani (soggetto referente del Distretto vivaistico ornamentale di Pistoia): evento riservato agli operatori del comparto. In apertura, dopo l’introduzione dei presidenti di AVI Michelucci e del Distretto Ferrini, gli interventi dell’assessora regionale all’agricoltura Saccardi, dell’assessore comunale al vivaismo Sgueglia e di docenti universitari, economisti e responsabili di servizi fitosanitari. Le testimonianze di due aziende leader dell’economia circolare in Toscana: Revet e Agribios.
Durante il convegno, che sarà aperto dagli interventi dei presidenti di AVI Alessandro Michelucci e del Distretto vivaistico ornamentale di Pistoia Francesco Ferrini e, a seguire, dell’assessora all’agricoltura della Regione Toscana Stefania Saccardi e dell’assessore al vivaismo del Comune di Pistoia Gabriele Sgueglia, verranno trattate le sfide con cui si confronta oggi il comparto vivaistico: «concorrenza globale, rischi di mercato, minacce fitosanitarie, aumento dei costi di produzione e avversità atmosferiche». Sfide nelle quali si celano anche «opportunità uniche», purché il vivaismo sappia dare risposte efficaci a domande quali le seguenti: come tutelare e valorizzare la qualità delle produzioni vivaistiche garantendo la sostenibilità economica e ambientale? In che modo si può trarre vantaggio dalla transizione verso l'economia circolare?
Queste e altre domande saranno al centro degli interventi degli importanti relatori, fra professori universitari, economisti e responsabili di servizi fitosanitari, del convegno di AVI, che sarà moderato dalla capocronista della Nazione Pistoia Elisa Capobianco e che si preannuncia come un’occasione unica di riflessione, discussione e progettazione del futuro del vivaismo a Pistoia e non solo.
Programma
Redazione
- Dettagli
- Scritto da Andrea Vitali
L’intervento del vice presidente della Comagri dell’Europarlamento Paolo De Castro al Pistoia Green Forum del 30 settembre: sui tempi di pagamento dobbiamo «individuare una soluzione adatta al settore vivaistico» insieme al sottosegretario La Pietra e al Ministro Lollobrigida, senza snaturare l’applicazione della Direttiva sulle pratiche sleali. E sul Regolamento europeo che impone -50% di fitofarmaci entro il 2030 ha detto: «oggi ho toccato con mano la riduzione di fitofarmaci nelle aziende» del Distretto, ma non si può dare un obiettivo così ambizioso «senza affrontare il come» e il nuovo Regolamento sulle Tea (le Tecniche di evoluzione assistita che possono aiutare la riduzione della chimica) è sul tavolo solo dal 5 luglio.
«Dobbiamo trovare una soluzione: non c’è dubbio che per il settore vivaistico non si possono utilizzare le stesse identiche regole che valgono per tutto il settore agroalimentare, perché il tema dei tempi di pagamento a 30 giorni per i prodotti deperibili e a 60 giorni per i prodotti non deperibili si scontra con una prassi che invece qui nel Distretto evidentemente ha applicazioni molto diverse».
È quanto dichiarato dall’ex ministro dell’agricoltura Paolo De Castro, attuale vice presidente della Commissione agricoltura e sviluppo rurale del Parlamento europeo, il 30 settembre nel suo intervento al Pistoia Green Forum, dopo che nel corso della giornata aveva fatto visita ad alcuni vivai del Distretto vivaistico ornamentale. Il riferimento è alla Direttiva (Ue) 2019/633 sulle “pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare” recepita in Italia col Decreto legislativo 198 del 2021 (vedi).
«Questo tema – ha detto De Castro - ha interessato molte delle chiacchierate con gli imprenditori in questo nostro straordinario distretto del vivaismo: 5.500 ettari circa di specializzazione così forte che ci hanno fatto diventare primi in Europa». Il Distretto infatti, ha continuato De Castro, «sta vivendo un momento complicato dall’entrata in vigore della Direttiva sulle pratiche commerciali sleali, la cui applicazione nel settore agroalimentare ha creato qualche difficoltà proprio nel settore vivaistico».
Come risolvere il problema? La soluzione per De Castro, che è stato uno dei promotori di questa normativa che tutela in particolare le aziende agricole nei rapporti con le grandi catene commerciali, è «individuare una soluzione che sia adatta al settore vivaistico senza andare a intercettare gli altri settori dell’agroalimentare. È questa la soluzione su cui oggi si è un po’ parlato negli incontri e adesso con il sottosegretario La Pietra ci metteremo a lavorare nelle prossime settimane e sono sicuro che il ministro Lollobrigida, che ha già manifestato pieno appoggio all’iniziativa, ci possa aiutare a trovare una soluzione che non snaturi l’applicazione di quell’importante provvedimento ma che dia una risposta concreta a un settore che evidentemente non può applicarla così come si applica nel settore lattiero-caseario piuttosto che nel settore ortofrutticolo».
Nella sua relazione Paolo De Castro si è soffermato anche sull’eredità di questa legislatura europea avviata alla conclusione nel settore agricolo, con la nuova Pac entrata in vigore quest’anno e improntata a Green Deal e transizione ecologica. «Stiamo vivendo una fase complicata – ha detto -. La transizione ecologica l’abbiamo capito tutti che la dobbiamo affrontare, ma la dobbiamo affrontare da protagonisti: una chiave che tutto il mondo agricolo e agroalimentare ha ben chiara». Ma «la sensazione che abbiamo a volte noi a Bruxelles – ha proseguito l’europarlamentare - è che gli agricoltori invece di essere protagonisti, o di essere considerati protagonisti, di questo Green Deal e quindi di essere loro lo strumento attraverso il quale si possono fare passi avanti importanti nella direzione della sostenibilità e verso i cambiamenti climatici, vengono visti più da imputati che da protagonisti. È questo l’elemento che crea oggi un po’ di frizione e di difficoltà».
Come mai? Soprattutto perché nell’anno dell’applicazione della nuova Pac (entrata in vigore il 1 gennaio 2023), una Pac «profondamente riformata» dopo 3 anni di negoziato e che sta creando «una serie di difficoltà applicative» come quelle relative agli eco-schemi, ecco proprio in questo contesto «sono arrivate una serie di nuove proposte di regolamenti che hanno evidentemente creato il malessere che oggi si respira anche da noi a Bruxelles». Fra gli esempi di regolamenti problematici per gli agricoltori citati da De Castro, il Regolamento sul ripristino della natura (vedi), «che ha visto l’agricoltura come imputata con una serie impegni al di là di quello che già la nuova Pac ha introdotto», e il Regolamento sui fitofarmaci (vedi), che impone di «ridurre del 50% l’uso dei fitofarmaci entro il 2030».
«Nessuno – ha precisato De Castro - può essere in disaccordo nel ridurre la chimica in agricoltura. Già si sta facendo tanto. Oggi ho visitato delle aziende in cui questo l’ho toccato con mano: la riduzione dell’uso dei fitofarmaci. Però gli agricoltori per poter raggiungere questi obiettivi hanno bisogno di strumenti concreti. Non si può dire soltanto obiettivo 50% entro il 2030 senza affrontare il come farlo. Ecco perché ci siamo arrabbiati, ecco perché insistiamo per esempio ad accelerare sulle Tecniche di evoluzione assistita [Tea, ndr], queste nuove tecniche genetiche non ogm che consentono di mettere a punto varietà resistenti senza utilizzare la chimica. L’Italia può essere già capofila in queste tecnologie. Pensate che in viticoltura noi oggi siamo in grado di fare cloni di vite resistenti alla peronospera e all’oidio con varietà resistenti senza un chilo di prodotto chimico. Però purtroppo l’Europa [leggi Commissione Europea, ndr] ci ha messo sul tavolo questo nuovo Regolamento sulle nuove tecniche genetiche soltanto il 5 luglio».
L’eredità di questa legislatura europea per l’agricoltura, ha concluso De Castro, è un po’ «pesante», ma «l’Italia ha sempre lavorato in squadra e non ci sono mai state divisioni quando si è trattato di difendere gli interessi nazionali sull’agricoltura e quindi abbiamo potuto correggere certe impostazioni» e certi eccessi delle normative. Comunque «chi verrà dopo di noi dovrà seguire questa direzione e non mettere in difficoltà un settore che sta facendo tanti sacrifici» e che durante il Covid ha saputo dimostrare anche tutta la sua forza e resilienza, senza mai interrompere le forniture di cibo.
L.S.
- Dettagli
- Scritto da Andrea Vitali
Il presidente dell’Associazione Vivaisti Italiani Michelucci, a margine del convegno di Flormart del 22 settembre sul “verde per la qualità della vita” e le “prospettive del Pnrr”, ha sottolineato che i contratti di coltivazione di piante sono una priorità per i vivaisti e ha sollecitato il Governo a pubblicare l’atteso bando dei contratti di distretto, che potrebbe consentire al Distretto vivaistico ornamentale di Pistoia di far scattare importanti investimenti per la transizione ecologica. Inoltre per Michelucci i vivaisti devono attrezzarsi per fornire la manutenzione delle piante vendute.
«I contratti di coltivazione saranno il futuro del nostro lavoro, perché, soprattutto in questa fase in cui la domanda di piante è alta, lo spazio produttivo è poco e va sfruttato al meglio e quindi bisogna programmare le piante che servono veramente, quelle che il mercato richiede».
È quando dichiarato venerdì scorso a Flormart da Alessandro Michelucci, presidente dell’Associazione Vivaisti Italiani (soggetto referente del Distretto vivaistico ornamentale di Pistoia), a margine del convegno “Il verde per la qualità della vita: attuazione e prospettive del Pnrr”, organizzato da Fiere di Parma in collaborazione con Anci e Associazione Pubblici Giardini, a cui è intervenuto anche il primo cittadino di Pistoia Alessandro Tomasi (vedi).
«Il sindaco Tomasi – è il commento di Michelucci - ha fatto una spiegazione veramente chiara anche di quanto sta succedendo nei Comuni adesso: le amministrazioni sono sempre più schiacciate dai tagli e non riescono a programmare nulla. Ma il verde che pianti il prossimo anno lo devi programmare, non è come comprare al supermercato. I buoni progetti di verde sono frutto di piantagioni in vari anni e di programmazione fino alla fase finale». «I contratti di coltivazione - ha continuato - consentono di mirare la produzione: nelle dimensioni giuste e tenendo conto dei requisiti richiesti dalle singole amministrazioni comunali o dagli Stati committenti, perché magari, tanto per fare un esempio, in certi Stati non vogliono l’uso di certi substrati».
«Un aspetto che sta venendo fuori adesso nei rapporti con le amministrazioni pubbliche – ha aggiunto il presidente Michelucci - è la manutenzione dopo la piantumazione e su questo parte del vivaismo di Pistoia è ancora indietro. Le aziende devono non solo vendere le piante ma essere in grado di (e avere il personale per) seguirle una volta vendute. In sintesi, dunque, contratto di coltivazione vuol dire: prenotazione, acconto all’inizio della produzione, possibilità di vederle in fase di coltivazione e poi dopo la vendita anche tot anni di manutenzione. Il pacchetto deve essere completo e le aziende devono strutturare il personale con una parte dedicata alla fase di manutenzione».
Prendendo spunto da uno dei punti toccati dal sindaco Tomasi nel suo intervento al convegno, il presidente di Avi Michelucci ha lanciato un appello al Governo affinché non tergiversi ancora nella pubblicazione del bando dei contratti di distretto nell’ambito del Pnrr. «Il bando dei distretti a Pistoia – ha dichiarato - sarebbe un vero volano di investimenti, molti nella direzione della transizione ecologica e con la creazione di posti di lavoro, che sono fra gli scopi del Pnrr. In tanti lo attendono, sia nel Distretto vivaistico ornamentale che in quello forestale di Pistoia, ma dopo tanti discorsi e rinvii non ne abbiamo saputo più niente».
L.S.
- Dettagli
- Scritto da Andrea Vitali
Il 30 settembre Pistoia sarà il fulcro toscano per il settore primario con tre focus e dibattito finale tra Tomasi, Giani e Marmo. Parteciperanno anche il sottosegretario La Pietra e l’assessore Stefania Saccardi.
La Sala Maggiore del Comune di Pistoia alle 15:30 accoglierà il “Pistoia GREEN Forum” un evento importante per confrontarsi sul il futuro sostenibile delle città toscane in chiave Europea. Il "Pistoia Green Forum" è organizzato dal Comitato Europeo delle Regioni (ECR) e vedrà la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni europee e nazionali. Un'opportunità per confrontarsi sui temi della sostenibilità sociale e ambientale, esplorare le direzioni future dell'Europa e discutere il ruolo delle amministrazioni locali nella transizione ambientale.
Tre sono i focus principali che verranno affrontati durante il forum:
1. Sostenibilità Sociale e Ambientale: Dove Va l'Europa?
In questa sessione, ascolteremo le voci di Nicola Procaccini, membro del Parlamento Europeo, e Paolo De Castro, membro del Parlamento Europeo. Questi esperti condivideranno le loro prospettive sul futuro dell'Europa in termini di sostenibilità sociale ed ambientale. Lorenzo Galligani, rappresentante del Comitato Europeo delle Regioni, e Nicola Danti, europarlamentare e Rappresentante Speciale per la Regione Europa, contribuiranno con le loro idee.
2. Istituzioni e Transizione Ecologica: Incontri con le Organizzazioni Professionali
La seconda sessione del forum porterà all'incontro tra le istituzioni e le principali organizzazioni professionali del settore primario. Saranno presenti rappresentanti di CIA, Confagricoltura e Coldiretti Pistoia. Un focus particolare sarà dedicato alla transizione ecologica, un tema cruciale in un'epoca in cui la sostenibilità è al centro dell'attenzione globale. Il Sottosegretario alle politiche agricole, forestali e sovranità alimentare Giacomo La Pietra e l'Assessore regionale all’agricoltura Stefania Saccardi raccoglieranno le istanze delle organizzazioni professionali di settore e porteranno la loro esperienza e le loro prospettive in questo importante dibattito.
3. Il Ruolo delle Amministrazioni Locali nella Transizione Ambientale
Infine, il terzo focus esaminerà il ruolo delle amministrazioni locali nella guida della transizione ambientale. Parteciperanno al dibattito il Sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi, il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, e il Presidente di provincia di Pistoia, Luca Marmo. Sarà quindi un'occasione per esplorare come le comunità locali possono contribuire in modo significativo alla creazione di un futuro sostenibile.
Il "Pistoia Green Forum" rappresenta un'opportunità aperta a tutti i cittadini della provincia di Pistoia e per tutti coloro che si interessano del settore primario, alla sostenibilità e al futuro dell'Europa.
Redazione
- Dettagli
- Scritto da Andrea Vitali
Consigliamo di esplorare l'unico parco Divertimenti Botanico al Mondo. Un'esperienza che fonde la bellezza botanica con l'emozione di un parco a tema, Terra Botanica è il sogno di ogni amante delle piante diventato realtà che attrae anche i giovani.
I veri amanti delle piante ora hanno una destinazione da sogno in Francia, dove il mondo delle piante si fonde con il divertimento di un parco a tema. Terra Botanica, situato nella pittoresca città di Angers, è una vera e propria oasi per gli appassionati di flora e fauna, offrendo un'esperienza che potrebbe essere la prima del suo genere al mondo.
A soli due ore e mezza di auto da Parigi, Terra Botanica è molto più di un giardino botanico tradizionale. Mentre offre l'opportunità di immergersi in una straordinaria varietà di piante - ben 275.000 diverse specie, per la precisione - va oltre, trasformando l'apprendimento in un'esperienza avvincente.
Tra le principali attrazioni di Terra Botanica ci sono le serre con microclimi diversi, che ospitano più di 2.000 varietà di orchidee. Puoi anche seguire percorsi tematici emozionanti, come "Sulla strada delle spezie", che ti guiderà attraverso una varietà di piante aromatiche provenienti da tutto il mondo. Inoltre, il giardino "intelligente" offre ai visitatori preziosi consigli su come risolvere i problemi comuni legati al giardinaggio.




Ma ciò che rende Terra Botanica davvero unico sono le emozionanti giostre e le attrazioni, che fanno sì che l'apprendimento sulle piante diventi un'avventura. Un giro in mongolfiera offre una vista a volo d'uccello dell'intero parco, mentre il "Viaggio in poche parole" è un'esperienza unica in cui ti siedi all'interno di un guscio di noce e viaggi tra le cime degli alberi del parco.
Il parco offre anche una straordinaria esperienza in 4-D, un'avventura con ologrammi e un tranquillo viaggio lungo la Loira su una chiatta in miniatura. Per gli amanti dei dinosauri, il giardino "Origins of Life" trasmette l'atmosfera di Jurassic Park, con la possibilità occasionale di incontrare un T. rex.
Terra Botanica è il primo parco divertimenti al mondo ispirato alla botanica, e non è una sorpresa che abbia già attirato oltre 450.000 visitatori. È un luogo dove la bellezza botanica si fonde con l'emozione di un parco a tema, creando un'esperienza indimenticabile per gli amanti delle piante di tutte le età. È una prova tangibile che imparare sulla natura può essere divertente, coinvolgente e pieno di sorprese.
Quindi, se hai un debole per la flora e sei alla ricerca di un'avventura botanica unica, visita Terra Botanica in Francia tra i segreti del regno vegetale. Maggiori informazioni sono disponibili sul loro sito web.
Il 2022 è stata una stagione storica per Terra Botanica ad Angers. In questa stagione sono passati dalle sue porte circa 460.000 visitatori, con un incremento del 40% rispetto al 2019, ultimo anno di riferimento. Dalla sua creazione nel 2010, la struttura non ha mai avuto un tale successo. Già l'estate scorsa ha visto la sua frequentazione estiva aumentare del 55% con 25.000 visitatori in più venuti per godersi “Terra Nocta”, il suo nuovo intrattenimento notturno e gli “animali straordinari”, gigantesche sculture vegetali, che raggiungono i 6 metri di altezza. “Vogliamo essere un parco dove scoprire, divertendoci, la straordinaria biodiversità del nostro pianeta. Ma Terra Botanica è anche un fantastico parco giochi attorno alle piante con creazioni artistiche, come queste gigantesche culture di mosaico, tra le più grandi d'Europa», indica il direttore del parco angioino, Pierre Watrelot.
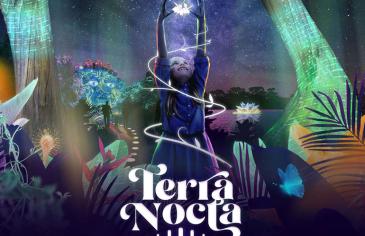





La scommessa è quindi vincente per Terra Botanica nonostante un inizio difficile. Nato per diventare una delle locomotive turistiche dell'Angiò, il parco ha mobilitato quasi 100 milioni di euro di investimenti da parte degli enti locali, dello Stato e dell'Unione Europea. Ma nel 2010, quando è stato inaugurato, il parco purtroppo non ha mantenuto la promessa di raggiungere la soglia di redditività fissata a 250.000 visitatori annui. La sua presenza di quasi 130.000 visitatori nel 2013 ha costretto le comunità a ricostituire il parco per evitare la dichiarazione di fallimento. Terra Botanica però è ora nella categoria dei grandi parchi a tema francesi con oltre 400.000 visitatori all'anno. Negli anni a venire, dichiara Pierre Watrelot, direttore del parco, si lavorerà su l’attrattiva del parco con diversi progetti di ampliamento.
A.V.
- Dettagli
- Scritto da Andrea Vitali
Fiori, piante e idee per il giardino, l'orto e il frutteto. Scopri il mondo affascinante degli alberi.
Caravino (TO) - Siete pronti per un'avventura nel mondo affascinante degli alberi? La Tre Giorni per il Giardino è pronta a stupirvi con l'Edizione Autunnale 2023, che avrà come protagonista indiscusso il re del regno vegetale, l'albero. Questo straordinario evento si terrà, come di consueto, al Castello e Parco di Masino, Bene del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS, a Caravino (TO), da venerdì 20 a domenica 22 ottobre dalle ore 10 alle 18.
L'Albero: Un Mondo tra Cielo e Terra
Come afferma il noto artista Bruno Munari, l'albero è l'esplosione lentissima di un seme, e questa edizione vuole celebrare la sua importanza come elemento chiave nell'ecosistema. Gli alberi non sono solo elementi naturali, ma veri e propri mondi brulicanti di vita. Recenti studi scientifici hanno rivelato quanto siano "intelligenti" queste maestose piante, in grado di comunicare tra loro e con altri organismi. Sono vere comunità aeree e sotterranee che regolano un complesso sistema di interconnessioni tra vegetali, funghi e microorganismi. Senza alberi, che mondo sarebbe il nostro? Questa edizione vuole approfondire questo tema cruciale per il nostro futuro, che inizia dal giardino di casa e si estende al giardino "planetario".
Un'Esperienza Unica
La Tre Giorni per il Giardino offre molto più di una tradizionale fiera di piante. Oltre alle novità proposte da oltre cento vivaisti italiani e stranieri, ci saranno incontri con esperti, laboratori per adulti e bambini, performance sonore ispirate agli alberi, e molto altro.
Gli Esperti e gli Ospiti
Tra gli ospiti illustri, avremo l'onore di ascoltare Antonello Pasini, fisico del clima al CNR, parlare delle varie facce e conseguenze del cambiamento climatico, Maria Teresa Della Beffa, agronoma e naturalista, ci porterà alla scoperta dell'alleanza tra piante e insetti pronubi per la salvaguardia del nostro ecosistema. Stefano Boeri ci presenterà il suo progetto "Green Obsession", che porta la natura nelle città. E molti altri esperti ci guideranno in un viaggio alla scoperta del mondo degli alberi.
Laboratori e Attività per Tutti
Ci saranno laboratori per adulti e bambini, dai laboratori di modellazione di terracotta all'intreccio di piante, fino alle performance sonore ispirate agli alberi. Sarà un'esperienza coinvolgente per tutta la famiglia.
Dove e Quando
La Tre Giorni per il Giardino si terrà presso il Castello e Parco di Masino a Caravino (TO) da venerdì 20 ottobre a domenica 22 ottobre, dalle ore 10 alle 18.
Biglietti e Informazioni
I biglietti possono essere pre-acquistati online sul sito tregiorniperilgiardino.it, con prezzi scontati. L'acquisto online garantisce anche l'accesso prioritario. Ulteriori informazioni, il programma completo e l'acquisto dei biglietti sono disponibili su tregiorniperilgiardino.it.
Non perdete l'opportunità di esplorare il mondo degli alberi e scoprire come contribuire a preservare la biodiversità a partire dal vostro giardino. La Tre Giorni per il Giardino vi aspetta per un'esperienza indimenticabile!
Redazione





