Notizie
- Dettagli
- Scritto da Andrea Vitali
Un’analisi di Coldiretti sul boom di orti in città dal rapporto Istat sul Verde Urbano, presentata a “Cibi d’Italia” di Campagna Amica a Milano la settimana scorsa, registra la cifra record di 1,1 milioni di mq di terreni urbani coltivati. Più di 20 milioni di italiani coltivano l’orto o curano il giardino occasionalmente. Per Coldiretti “la crisi economica ci riporta ai tempi di guerra”.
Mai così tante aree verdi sono state destinate ad orti pubblici nelle città, dove si è raggiunto il record di 1,1 milioni di metri quadri di terreno di proprietà comunale divisi in piccoli appezzamenti e adibiti alla coltivazione ad uso domestico, all’impianto di orti e al giardinaggio ricreativo. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base del rapporto Istat sul Verde Urbano presentata in occasione di “Cibi d’Italia” di Campagna Amica al Castello Sforzesco di Milano, dove si sono svolte vere lezioni pratiche per diventare “hobby farmer”, con figure dedicate che opereranno progressivamente in tutta Italia, dove si registra un vero boom con circa 21 milioni di italiani che stabilmente o occasionalmente coltivano l’orto o curano il giardino.
Le coltivazioni degli orti urbani non hanno scopo di lucro, sono assegnati in comodato ai cittadini richiedenti e forniscono prodotti destinati al consumo familiare e, oltre a rappresentare un aiuto per le famiglie in difficoltà, concorrono a preservare spesso aree verdi interstiziali tra le aree edificate per lo più incolte e destinate all’abbandono e al degrado. Secondo il censimento effettuato dall’Istat quasi la metà (38 per cento) delle amministrazioni comunali dei capoluoghi di provincia - sottolinea la Coldiretti - ha previsto orti urbani tra le modalità di gestione delle aree del verde, con forti polarizzazioni regionali: il 72 per cento delle città del Nord-ovest, poco meno del 60 per cento e del 41 per cento rispettivamente nel Nord-est e nel Centro (con concentrazioni geografiche in Emilia-Romagna e Toscana, ma ben rappresentati anche in Veneto, Friuli-Venezia Giulia e nel Lazio). Nel Mezzogiorno, infine, risultano presenti solo a Napoli, Andria, Barletta e Palermo.
La crisi economica - rileva la Coldiretti - fa dunque ricordare i tempi di guerra quando nelle città italiane, europee e degli Stati Uniti si diffondevano gli orti per garantire approvvigionamenti alimentari. Sono famosi i “victory gardens” degli Stati Uniti e del Regno Unito dove nel 1945 venivano coltivati 1.5 milioni di allotments sopperendo al 10 per cento della richiesta di cibo. Ma sono celebri anche gli orti di guerra italiani nati al centro delle grandi città per far sì che, nell'osservanza dell'imperativo del Duce, “non (ci fosse) un lembo di terreno incolto”. Sono negli annali della storia le immagini del foro Romano e di piazza Venezia trasformati in campi di grano e la mietitura svolta in piazza Castello, centro e cuore di Torino in ogni epoca.
Ora i tempi sono cambiati ed ai motivi economici si sommano quelli di volersi garantire cibo sano da offrire a se stessi e agli altri od anche la voglia di voler trascorrere piu’ tempo a contatto con la natura. Una tendenza che continua la Coldiretti - si accompagna anche da un diverso uso anche del verde privato con i giardini e i balconi delle abitazioni che sempre piu’ spesso lasciano spazio ad orti per la produzione “fai da te” di lattughe, pomodori, piante aromatiche, peperoncini, zucchine, melanzane, ma anche di piselli, fagioli fave e ceci da raccogliere all’occorrenza. Con la crisi fare l’orto è diventato - sostiene la Coldiretti - una tendenza assai diffusa che ha raccolto molti appassionati che possono oggi scegliere tra le tante innovazioni presenti sul mercato anche a seconda dello spazio disponibile. Dall’orto portatile a quello verticale, dall’orto “riciclabile” a quello in terrazzo, da quello rialzato a quello didattico, ma anche l’orto urbano e le tecniche di “guerrilla gardening” che possono essere adottate da quanti non hanno spazi disponibili per piantare ortaggi e frutta nei terreni disponibili nei centri delle città.
Gli “hobby farmers”– spiega la Coldiretti – sono una fascia di popolazione composta da giovani e anziani, da esperti e nuovi appassionati, che coltivano piccoli appezzamenti famigliari, strisce di terra lungo ferrovie, parchi e campi di calcio, balconi e terrazzi arredati con vasi di diverse dimensioni o piccole aree con acqua e sgabuzzino per gli attrezzi messe a disposizioni dai comuni in cambio di affitti simbolici.
Nel caso di orto su un balcone di medie dimensioni si può ipotizzare un costo che oscilla fra i 40 e i 50 euro per 2 contenitori da 80 centimetri di lunghezza, con la giusta quantità di terra e 6 piantine orticole più diverse essenze aromatiche, dove la maggior parte del costo è rappresentato proprio dai vasi che certamente non si buttano via a fine stagione, ma possono essere riutilizzati per più anni. Le singole piantine orticole possono costare fra i 25 e i 30 centesimi per confezioni multiple. Il segreto del piccolo orto sul balcone - spiega Coldiretti - sta nell’ottimizzare gli spazi all’interno degli stessi vasi, alternando piante più alte come pomodorini, peperoni e melanzane, con alla base composizioni di prezzemolo, basilico ed erbette. L’ideale è attrezzare un lato del balcone con le orticole e l’altro con le aromatiche (come timo, salvia e menta).
Se invece si ha a disposizione un piccolo appezzamento di terreno, in appena 10 metri quadrati si possono coltivare: 4 piante di pomodori, 4 piante di melanzane, 2 piante di zucchine, 8 piante di insalata e 4 piante di peperoni per una produzione media di oltre 25 chili di verdura. Oltre a quello sul balcone o al tradizionale a terra, a causa degli spazi sempre più ristretti nelle città – conclude Coldiretti – stanno nascendo anche nuove tipologie di orti: da quelli a parete che si appendono all’esterno e nei quali trovano spazio fragoline, peperoncini, insalatine ed erbe aromatiche o quelli “pocket” costituiti da mini vasi in materiale riciclabile che possono essere sistemati senza problemi anche a bordo finestra sui davanzali più stretti.
LE DIVERSE TIPOLOGIE DI ORTO
L’orto a porter ovvero l’orto da passeggio è forse quello più bizzarro ed è scelto da coloro i quali vogliono essere veramente alla moda. Si tratta - spiega la Coldiretti - di piccoli vasi o bicchieri meglio se in bioplastica con pianticelle da portare in giro e una volta a casa adagiare su un substrato più “comodo”.
L’orto verticale invece è da preferire quando lo spazio scarseggia. Una delle tante soluzioni può essere quella di creare dei pannelli di legno in varie dimensioni con un substrato fertile e tante tasche, che possono essere anche di stoffa, dentro alle quali piantare e coltivare verdure o fiori con radici poco profonde.
L’orto riciclato è l’ideale per coloro che non vogliono sprecare plastica o vetro. Basta inventare un piccolo vaso utilizzando vecchie bottiglie in plastica tagliate, tetrapak, scatole di alluminio, contenitori in polistirolo ecc per piantare simpatiche piantine da orto da far crescere rispettando l’ambiente.
L’orto in terrazzo è sicuramente il più diffuso in Italia. Anche in poco spazio in terrazzo un bel vaso può ospitare piante officinali, spezie e qualche piccolo ortaggio stando ben attenti all’esposizione solare e alla quantità di acqua da somministrare alle piante.
L’orto rialzato viene scelto - riferisce la Coldiretti - da chi non dispone di un giardino o un lembo di terra, ma ha ampio spazio in cemento da poter sfruttare oppure non è nelle condizioni di potersi chinare per lavorare la terra. Allora si utilizzando dei vasconi, meglio se in legno di cedro in cui poter piantare ortaggi, frutta e fiori.
Attraverso l’orto didattico, diffuso nelle scuole e nelle aziende agrituristiche di Campagna Amica - Terranostra aperte ai bambini, si apprendono la stagionalità, la cultura della campagna e i suoi valori storici, economici e sociali. I ragazzi capiscono l’importanza delle tradizioni contadine, lo stretto legame con la natura e l’importanza del rispetto dell’ambiente. In una società sempre più a rischio di cementificazione è molto importante dedicare attenzione alle “pratiche verdi” anche tra banchi e lavagne ed è bellissimo vedere i giardini delle scuole sottratti all’incuria, fiorire e diventare luogo di gioco e apprendimento per bambini e ragazzi.
Fonte Ufficio Stampa
- Dettagli
- Scritto da Andrea Vitali
Con il bando “Agrifood”, in scadenza il 21 giugno 2013, si promuovono progetti integrati di ricerca agroalimentari fra imprese ed enti toscani, puntando su temi quali valorizzazione delle proprietà salutistico-nutrizionali e rapporto fra prodotto e paesaggio, sicurezza alimentare e tracciabilità, ampliamento delle gamme commerciali.
Da venerdì scorso è attivo il bando “Agrifood” finalizzato a promuovere e sostenere progetti integrati di ricerca di università e enti di ricerca operanti in Toscana, che potranno presentare domanda in collaborazione con imprese entro e non oltre il 21 giugno 2013.
“Una importante opportunità per il sistema regionale della ricerca in stretto raccordo con il sistema produttivo nel settore agricolo e agroalimentare, compreso quello ittico”, come lo definiscono la vicepresidente della Regione Toscana Stella Targetti, con delega alla ricerca, e l’assessore all’agricoltura Gianni Salvadori.
I progetti di ricerca fondamentale e industriale, realizzati in Toscana, dovranno riguardare temi quali la valorizzazione delle proprietà salutistico-nutrizionali degli alimenti tradizionali e innovativi, lo sviluppo di nuove tecnologie e strumenti per garantire la sicurezza della catena alimentare, la valorizzazione degli aspetti di qualità del prodotto e del rapporto tra prodotto, paesaggio, cultura e storia, la tracciabilità dei prodotti e l’ampliamento della gamma commerciale con prodotti innovativi.
Il bando prevede di destinare la somma iniziale di euro 600.000 (eventualmente integrabile da altre fonti di finanziamento) per sostenere i progetti integrati, la cui copertura finanziaria risulta garantita dagli stanziamenti del bilancio di previsione 2012 (400.000 provenienti dall’Area di coordinamento Ricerca e 200.000 dall’Area di coordinamento Sviluppo rurale). Il coordinamento operativo è stato affidato all’Area di coordinamento Ricerca, che ha operato attraverso un gruppo di lavoro intersettoriale tra i due assessorati.
“Questo bando – spiega la vicepresidente Targetti – mira a promuovere ricerche che possono andare in tre direzioni. Primo, tutelare i consumatori migliorando la tracciabilità dei cibi e quindi la sicurezza alimentare, con particolare attenzione alle nostre eccellenti produzioni locali nell’ottica della certificazione di qualità. Secondo, incentivare ricerche sull’uso di quegli alimenti che possono migliorare la salute dell’uomo e che puntano, terzo aspetto, a migliorare anche la catena commerciale dei prodotti toscani. La nostra volontà è quella di stimolare idee innovative: il bando è infatti aperto a professionalità e competenze interdisciplinari, non solo quelle tipiche di chi lavora nell’agroalimentare, ma trasversali a diversi settori”.
“Abbiamo recepito con questo bando – afferma l’assessore all’agricoltura Salvadori – gli indirizzi europei in materia di Politica Agricola Comune 2014-2020, che invitano a favorire rapporti sempre più stretti tra mondo della ricerca e mondo delle imprese, perciò abbiamo ritenuto opportuno non disperdere il sistema di relazioni avviato con l’esperienza del tavolo regionale di confronto per l’adesione al Cluster nazionale Agrifood. Abbiamo così creato una ‘Piattaforma regionale per l’agroalimentare’ che stimoli un confronto costruttivo e collaborativo tra i rappresentanti delle università e degli enti di ricerca toscani, del mondo imprenditoriale e della Regione. Inoltre – conclude Salvadori – le tematiche prescelte sono legate strettamente a quelle di Expo 2015, ‘Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita’. Daremo visibilità con questo evento alla tradizione, alla creatività e all’innovazione nel settore dell’alimentazione e della sicurezza alimentare”.
Il testo del bando con tutti gli allegati, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, è consultabile anche all’indirizzo www.regione.toscana.it/ricercapraf.
Fonte Ufficio Stampa
- Dettagli
- Scritto da Andrea Vitali
Con il “Terranostra Day” del 12 maggio, da Roma a Milano in bus gratis verso 11 agro-itinerari nella campagna toscana. L’iniziativa di promozione degli agriturismi di Campagna Amica (Coldiretti) coinvolge oltre 100 strutture della regione alla scoperta del Made in Tuscany tra assaggi, lezioni, dimostrazioni, visite. Ecco come prenotare, anche per chi preferisce il mezzo privato.
Da Roma e Milano alla scoperta del Made in Tuscany. Il viaggio in pullman è gratuito. Basta solo prenotare e farsi trovare al punto di partenza all’ora prestabilita per vivere un’esperienza indimenticabile tra colline e preziosi filari, stalle e prati verdissimi nel cuore della regione più ricca ed invidiata del mondo.
Le porte di oltre 100 strutture agrituristiche della Toscana si aprono domenica 12 maggio in occasione di “Terranostra Day” la più importante iniziativa di promozione turistico-eno-gastronomica promossa da Terranostra e Agriturismo di Campagna Amica (info su www.toscana.coldiretti.it) che offre a turisti, cittadini in fuga dalla routine, amanti del mangiare bene e del buon cibo, appassionati di scampagnate, cultori del km zero ed esploratori seriali, 11 agro-itinerari per guardare la Toscana da angolature diverse attraverso visite guidate a cantine, frantoi, caseifici, assaggi, merende, degustazioni di prodotti tipici, lezioni e dimostrazioni pratiche per imparare a cucinare, a riconoscere le erbe, preparare passate o conserve, persino fare la pasta in casa.
Dalla Valdichiana nell’aretino alla Val d’Orcia passando per le Crete Senesi, la Terra di Luni, la Lunigiana delle Statue Steli e la Garfagnana, la Costa degli Etruschi e le Colline Metallifere, nel pisano, “Terranostra Day” è un modo originale, divertente, educativo, interattivo per vedere, assaporare, toccare con mano, provare e partecipare, da protagonista, ad un’esperienza che ha l’obiettivo di “portare” - letteralmente - il cittadino-consumatore fin dentro le aziende agricole dove nascono con amore e passione, rispetto delle tradizioni e soprattutto della natura, i prodotti che compongono lo straordinario paniere del Made in Tuscany. Un viaggio genuino, andata e ritorno, nella Toscana della campagna coltivata.
E per chi non vuole (o non può) viaggiare in pullman c’è anche l’opzione “fai da te” per tutti coloro che, per esigenze personali, preferiscono viaggiare e raggiungere le strutture agrituristiche che hanno aderito con un mezzo privato: c’è solo l’imbarazzo della scelta. Basta prenotarsi. In tempo però…
La campagna Toscana ti aspetta.
COME PRENOTARE
Con il bus gratuito: come prenotarsi?
Per utilizzare il servizio di trasporto gratuito messo a disposizione da Roma e da Milano è necessario collegarsi al sito www.toscana.coldiretti.it, cliccare sull’apposita sezione “Terranostra Day” in alto, nel centro del portale, accedere a “Con il bus gratuito”, visionare i percorsi e successivamente selezionare quello prescelto, scaricare, compilare ed inviare il modulo di prenotazione alla segreteria di riferimento. Entro pochi giorni la segreteria provvederà ad inviare la conferma di prenotazione.
Con un mezzo privato: come prenotare la visita “fai da te”?
Per visitare una delle aziende che hanno aderito è necessario collegarsi al sito www.toscana.coldiretti.it, cliccare sull’apposita sezione “Terranostra Day” in alto, nel centro del portale, accedere a “Con un mezzo privato”, visionare le destinazioni e successivamente selezionare l’azienda prescelta. Per prenotare la visita è sufficiente telefonare o inviare una mail direttamente all’azienda.
Per saperne di più www.toscana.coldiretti.it oppure sul profilo Facebook “Coldiretti Toscana”..
Fonte Ufficio Stampa
- Dettagli
- Scritto da Andrea Vitali

Siglato nelle Terre di Siena un protocollo di intenti tra la Cooperativa Antigone servizi e l’associazione nazionale Città del bio: grazie anche al format Toscaneria, sarà organizzata una filiera distributiva efficiente per i prodotti tipici e dell’agricoltura biologica toscani, in modo da garantire la remunerazione del lavoro agricolo e un’offerta di qualità.
- Dettagli
- Scritto da Andrea Vitali
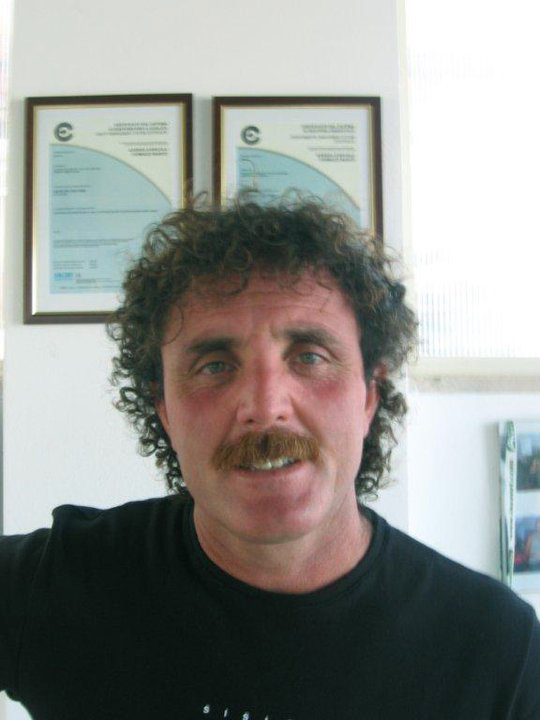
Dal presidente del distretto floricolo Lucca-Pistoia Marco Carmazzi un documento che lancia un vero grido d’allarme con annessa richiesta di soccorso per la crisi nera che ha colpito il settore ortoflorovivaistico regionale: fra maltempo, vendite crollate del 50% e fatturato del 50-70%, un danno stimato intorno a 60 milioni di euro. Ecco il testo firmato da Carmazzi sotto il titolo “L’evolversi della crisi economica nell’ortoflorovivaismo”.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



