Vis-à-vis
- Dettagli
- Scritto da Andrea Vitali
A colloquio con Alberto Manzo, funzionario del Mipaaf responsabile del tavolo di filiera del florovivaismo, incontrato durante Flormart 2017. E’ aperto a un eventuale Gruppo di lavoro sui mercati di fiori, a beneficio in primis del fiore reciso. Per lui nelle produzioni florovivaistiche italiane c’è qualità, ma i rischi fitosanitari causati dall’import-export di piante esistono: i principi del Reg. Ue 2031 di tutela delle piante vanno rispettati, abbassando però l’eccessivo carico burocratico del regolamento.
«L’incontro dei mercati di fiori è stato interessante. L’idea è quella di realizzare un gruppo di lavoro nell’ambito del tavolo tecnico del florovivaismo, “Gruppo lavoro mercati”, per riprendere un discorso che è stato fatto già negli anni scorsi dal tavolo riguardo ai progetti Ismea sulla certificazione del materiale, per cercare di dare una svolta e un aggiornamento soprattutto al settore dei fiori recisi. Per cui adesso Piante e Fiori d’Italia farà una nota ufficiale al Ministero e lo proporrà come gruppo di lavoro del tavolo tecnico di filiera».
Inizia così la breve intervista di Floraviva ad Alberto Manzo, funzionario del Ministero delle politiche agricole che coordina il tavolo tecnico di filiera del florovivaismo, sentito durante la 68^ edizione di Flormart a Padova, dopo l’incontro sui mercati di fiori del 22 settembre pomeriggio, in cui è stata annunciata dal presidente di Piante e Fiori d’Italia Cristiano Genovali la nascita di un tavolo dei mercati di fiori italiani, per ora all’interno dell’associazione da lui guidata (vedi nostro articolo).
Ad Alberto Manzo chiediamo ragguagli anche sull’incontro del 27 settembre a Roma fra florovivaisti, esperti e politici, sia parlamentari che ministri, sul tema “Il paesaggio chiama politica: economia, salute, sviluppo, occupazione e turismo per un’Italia sostenibile”, organizzato dal Coordinamento nazionale della filiera del florovivaismo e del paesaggio (Cnffp), che ha quali referenti Nada Forbici, presidente di Assofloro Lombardia, e Francesco Mati, presidente del Distretto vivaistico ornamentale di Pistoia (vedi nostro articolo).
«Si tratta dell’ennesimo appuntamento alla Camera dei deputati organizzato da aziende che hanno a cuore tutto il discorso degli incentivi per il verde, cioè il recupero dei giardini privati con la disponibilità di un budget messo a disposizione per attivare un bonus verde…»
..ci sarà anche il suo Ministero?
«Il ministero è stato invitato e probabilmente verrà. Diciamo che è gestito da dei parlamentari che hanno avuto a cuore …»
..i tre disegni di legge di defiscalizzazione di opere a verde private?
«Sì, uno è quello dell’onorevole Susta, che ha parlato anche questa mattina a “EchoTechGreen”, e ha ribadito la proposta di emendamento che dovrà essere riproposta in finanziaria. Vediamo però…»
..ci hanno già provato ma sono mancate le risorse..
«Tutti [nel settore, ndr] sono concordi nel dire: partiamo con un po’ di fondi e vediamo. Però quando si arriva alla ripartizione dei fondi… vedremo».
Cosa è emerso nel convegno internazionale “Horticultural Experiences”?
«Sono state affrontate le tematiche del green, cioè sull’importanza del verde urbano, sempre gli stessi concetti ma più aggiornati. E anche nella mia sezione sulle produzioni di qualità abbiamo parlato più o meno dello stesso discorso toccato nella riunione dei mercati di fiori, cioè l’importanza di alzare la qualità del prodotto garantendo un prodotto adeguato a livello internazionale. Infatti ha parlato Mps, ha parlato l’ufficio dei brevetti europeo di Angers (Cpvo, Community plant variety office Eu agency, ndr), e questo discorso vale per tutti i comparti del florovivaismo. La questione è internazionale, non solo italiana. Il punto è che la qualità delle produzioni in questo settore si scontra con altre problematiche. Infatti un altro tema è stato quello della movimentazione del materiale con problemi fitosanitari, vedi Xylella ecc.; e quindi dell’aumento dei controlli, della necessità di avere cura di controllare le aziende. Tutte tematiche assolutamente legate fra loro e che hanno come conseguenza il fatto di fornire al consumatore un prodotto garantito».
In Italia come si sta da questo punto di vista della qualità delle produzioni e delle garanzie?
«A livello di qualità siamo messi molto bene, perché le aziende italiane sono serie e fanno un buon lavoro. Però c’è anche qui competitività sui mercati e alcuni sì hanno la certificazione, ma a mio avviso, coltivando anche all’estero, importando e inserendo il prodotto nel mercato europeo, si creano problemi nelle nostre aziende. Comunque è un discorso di cui parliamo da tanti anni, non è una novità».
L’unico punto nuovo, però, è il regolamento Ue 2016/2031 (vedi nostro articolo) contenente le misure per la protezione delle piante da organismi nocivi…
«..non è competenza del tavolo florovivaistico…»
..sì, ma una sua opinione è importante.
«L’opinione è che l’applicazione di quel regolamento è sicuramente molto complessa per le aziende e dispendiosa…»
..quindi si potrebbe sperare in un ammorbidimento delle norme..
«..non è che si può ammorbidire, il regolamento è quello, è scritto così, difficilmente si può ammorbidire. Si possono piuttosto cercare delle strade, non per abbassare il livello di quanto scritto, ma per trovare dei sistemi più idonei affinché le aziende non soffrano, perché proprio adesso che stanno uscendo dalla crisi..»
..mi pare che il punto dolente sia proprio il carico burocratico in più che impone, soprattutto quando richiede di tracciare tutto, anche i movimenti interni a un vivaio..
«Il problema è proprio questo: abbassare il livello burocratico della carta pur restando ancorati a quei principi».
Questo si può fare?
«Sì, questo si può fare, dobbiamo trovare dei sistemi più semplici».
Lorenzo Sandiford
- Dettagli
- Scritto da Andrea Vitali
Il Gruppo per la Floristica, Sistematica ed Evoluzione della Società Botanica Italiana, di cui il prof. Lorenzo Peruzzi (Dipartimento di Biologia dell’Università di Pisa) è coordinatore, dal 2010 dedica molta attenzione alle piante endemiche italiane, ovvero quelle che nascono spontaneamente solo qui. Dal primo censimento delle località-tipo, dove queste piante sono state descritte per la prima volta, emerge che circa un terzo di esse non è soggetto ad alcuna tutela e rischia il degrado.
Il Gruppo per la Floristica, Sistematica ed Evoluzione della Società Botanica Italiana, di cui lei è coordinatore, di che cosa si occupa nello specifico?
L'interesse scientifico principale è quello di documentare la diversità e la distribuzione delle piante spontanee, in particolare relativamente alla flora italiana. Nell'ambito della flora italiana, una componente di particolare pregio è quella endemica, cioè esclusiva, del territorio italiano.
Quali sono gli studi effettuati dal Gruppo fino ad oggi?
Dal 2010, che fu anno internazionale della biodiversità, il Gruppo ha dedicato molta attenzione alle piante endemiche italiane, di cui è stato pubblicato nel 2014 un primo elenco (continuamente aggiornato online) e una breve sintesi di alcuni aspetti storici. Nel 2015, sono state definite le località-tipo ricavate dai protologhi (cioè dai lavori scientifici dove una certa specie viene descritta per la prima volta) e quest'anno abbiamo pubblicato una sintesi sul valore conservazionistico delle località tipiche in tassonomia, la scienza che ha come scopo la catalogazione e classificazione dei viventi.
Quali sono i principali dati emersi da questa prima sintesi sulle località-tipo?
Quello da noi effettuato è il primo censimento in Italia delle località-tipo, cioè di quei luoghi dove sono state descritte per la prima volta le circa 1.400 piante endemiche italiane, quelle che nascono spontanee solo nel nostro Paese. Secondo quanto emerge dal censimento e considerando tutto il territorio italiano, sono 670 le località-tipo che si trovano sulle isole, mentre 866 sono sulla terraferma. Il maggior numero di siti si trova poi lungo la costa mediterranea (1.134), segue per numerosità la regione alpina (306) e quindi quella continentale (96). Per quanto riguarda infine la tutela del territorio, 1030 siti rientrano in aree protette, mentre 506 sono al di fuori e di questi 259 si trovano sulle isole.
Dunque circa un terzo delle località esaminate si trovano in aree non soggette ad alcuna tutela…
Proprio a partire dal caso studio sulle endemiche italiane, ci siamo resi conto che le località-tipo non sono state mai sinora prese in considerazione dalla comunità scientifica tra i criteri per definire un'area protetta. Ciononostante, la loro salvaguardia è importantissima sia dal punto di vista scientifico che dal punto di vista culturale. È universalmente riconosciuto che le popolazioni che crescono nelle località-tipo sono di fondamentale importanza in tassonomia, come riferimento e confronto con altre specie. Al contempo, però, le località-tipo rappresentano un importante patrimonio storico-culturale, in quanto luoghi visitati, studiati e descritti da rilevanti personalità nella storia della Botanica e delle Scienze naturali.
Cosa possiamo fare allora per proteggere queste preziose aree dove crescono le piante endemiche italiane?
Le strategie per la loro conservazione potrebbero muoversi in due direzioni: l'istituzione di "plant micro-reserves" (piccole aree protette) e/o riconoscimento dei siti come patrimonio culturale.
Il primo concetto, quello di “plant micro-reserves”, non è molto conosciuto in Italia, può spiegarci meglio di cosa si tratta?
Il concetto di "plant micro-reserves" è nato all'inizio degli anni '90 in Spagna (con esempi di applicazione - tramite progetti LIFE - anche in altre nazioni europee). Si tratta di un network di piccoli siti sperimentali soggetti a tutela e monitoraggio, istituiti per singole specie vegetali di particolare interesse. Tali siti dovrebbero andare ad aggiungersi al sistema di aree protette già esistente sia a livello italiano (es. Parchi Nazionali, Parchi Regionali ecc.) che europeo (es. Direttiva Habitat) ed ovviamente avere un riconoscimento dal punto di vista legislativo (cosa che, ad oggi, avviene solo in Spagna e in Lettonia).
In qualità di Gruppo di ricerca, in quale direzione proseguiranno adesso i vostri studi?
Il nostro prossimo passo, come Gruppo, sarà di estendere questo studio a tutto il resto della flora italiana: tutte le specie non endemiche (la cui distribuzione naturale, quindi, non è ristretta al territorio italiano). Incluse le endemiche italiane di cui abbiamo parlato, la flora spontanea italiana ammonta a oltre 7.600 specie e sottospecie. Tra di esse, infatti, vi è un analogo numero (ca. 1.400 entità) di specie descritte per la prima volta per l'Italia.
Anna Lazzerini
- Dettagli
- Scritto da Andrea Vitali
Intervista a Keese Janssen, che ci introduce la sua azienda specializzata in piante tropicali da interno e ci informa del positivo 2017: +25% in quantità a fine maggio. La pianta più cara? Un Ficus da 12 mila euro. Fachjan ha acquistato un nuovo vivaio che avvierà la produzione fra pochi mesi.
 I Flower Trials, la grande kermesse degli ibridatori di piante in vaso e da aiuola (e non solo) in corso in questi giorni nelle regioni olandesi di Aalsmeer e Westland e in quella tedesca di Rheinland Westfalen, sono stati l’occasione per una visita fuori programma alla sede di Fachjan, azienda olandese leader europea nelle produzioni di piante tropicali e subtropicali da interno (indoor). Qui Floraviva ha incontrato e intervistato il proprietario Keese Janssen, anzi l’ex titolare, visto che ha passato la mano ai suoi figli (anche se, come dice lui, è «contento di continuare a lavorarci»).
I Flower Trials, la grande kermesse degli ibridatori di piante in vaso e da aiuola (e non solo) in corso in questi giorni nelle regioni olandesi di Aalsmeer e Westland e in quella tedesca di Rheinland Westfalen, sono stati l’occasione per una visita fuori programma alla sede di Fachjan, azienda olandese leader europea nelle produzioni di piante tropicali e subtropicali da interno (indoor). Qui Floraviva ha incontrato e intervistato il proprietario Keese Janssen, anzi l’ex titolare, visto che ha passato la mano ai suoi figli (anche se, come dice lui, è «contento di continuare a lavorarci»).Interview with Keese Janssen, who presents his company, specialized in indoor tropical plants, and inform us about the positive 2017: +25% plants sold in the first five months. The most expensive plant? A Ficus that costs 12.000 euros. Fachjan has bought a new nursery that will start production in a few months.
 Flower Trials 2017, the great event, from 13th to 16th June, in which 59 breeding companies in three regions (Aalsmeer, Westland and Rheinland Westfalen) present their latest innovations and future developments mainly in pot and bedding plants, were the occasion for a visit to the greenhouse complex of Fachjan, top player in Europe in the production of indoor tropical and subtropical plants. Here Floraviva has met and interviewed the owner, Keese Janssen, or rather the previous owner, given that he passed the company's ownership to his two sons (even if, as he says, «he is happy to continue to work»).
Flower Trials 2017, the great event, from 13th to 16th June, in which 59 breeding companies in three regions (Aalsmeer, Westland and Rheinland Westfalen) present their latest innovations and future developments mainly in pot and bedding plants, were the occasion for a visit to the greenhouse complex of Fachjan, top player in Europe in the production of indoor tropical and subtropical plants. Here Floraviva has met and interviewed the owner, Keese Janssen, or rather the previous owner, given that he passed the company's ownership to his two sons (even if, as he says, «he is happy to continue to work»).- Dettagli
- Scritto da Andrea Vitali
Il direttore Burchi spiega le novità sancite il 31 marzo dalla pubblicazione in Gazzetta del decreto di adozione del nuovo statuto del Crea e annuncia che oltre al florovivaismo, d’ora in poi inclusivo delle aromatiche, il suo Centro si occuperà di orticoltura e piante da biomassa. Fra le ricerche in corso, un’ortensia da fiore reciso per un’azienda di Sanremo, il miglioramento genetico del Limonium sinensis per una di Viareggio, un sistema di gestione a distanza dei giardini per un vivaista pistoiese. Al via una collaborazione col Mefit per una calla di Pescia e con Coripro e Vivai di Pescia per olivi virus esenti.
- Dettagli
- Scritto da Andrea Vitali
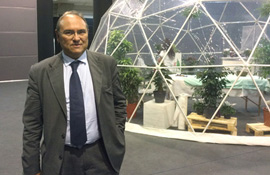



 Intervista al presidente di Cia, a Firenze per l’assemblea regionale, che dice: non bastano piccole modifiche alla Pac e bisogna premiare «non le aziende efficienti, ma filiere efficienti». Dino Scanavino propone un piano straordinario di manutenzione ordinaria del territorio affidato agli agricoltori. L’abolizione dei voucher è «sciagurata» e nella legge sul caporalato, appoggiata da Cia, vanno corrette le norme che trasformano in reati penali dei banali illeciti amministrativi.
Intervista al presidente di Cia, a Firenze per l’assemblea regionale, che dice: non bastano piccole modifiche alla Pac e bisogna premiare «non le aziende efficienti, ma filiere efficienti». Dino Scanavino propone un piano straordinario di manutenzione ordinaria del territorio affidato agli agricoltori. L’abolizione dei voucher è «sciagurata» e nella legge sul caporalato, appoggiata da Cia, vanno corrette le norme che trasformano in reati penali dei banali illeciti amministrativi.